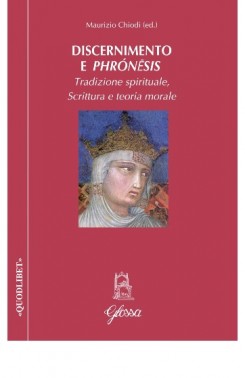
Maurizio Chiodi (ed.)
14 luglio 2023
Discernemento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria morale, analyse le sujet du discernement à partir de trois axes complémentaires: l’expérience morale et spirituelle, la Sainte Écriture et le dialogue avec la philosophie, afin de démontrer comme dans le livre précédent l’enracinement des normes dans l’expérience pratique selon une herméneutique circulaire qui oblige à repenser le lien entre conscience et prudence. Chiodi est non seulement l’éditeur de ce collectif des facultés d’Italie septentrionale et de Padoue, mais aussi le principal auteur, tout en sollicitant une approche interdisciplinaire (spiritualité, exégèse, philosophie). Dans la première partie de l’ouvrage, sur « l’expérience morale et l’expérience spirituelle », Chiodi critique le fait que Thomas ne comprenne pas l’expérience affective comme forme constitutive de l’expérience morale (p. 16), si bien que son intellectualisme éloigne la morale scolastique de la totalité de l’expérience et masque la contribution de la culture. On ne peut penser aujourd’hui l’accès à l’anthropologie ou à l’universel qu’à partir d’une expérience culturelle particulière. Le rapport à la vérité prend un caractère dialogal, alors même que le sujet est confronté à une incertitude de ses fins et de ses désirs. Dans le deuxième chapitre, il indique la nécessité de surmonter la juxtaposition de la morale et de la spiritualité. Le théologien Ezio Bolis complète cette critique de la tradition en exposant « le discernement spirituel chez saint Ignace de Loyola et saint François de Sales » (p. 70-110), à travers l’attention aux affects, à la pratique de microdécisions, ou au travail sur la volonté pour consentir à la volonté de Dieu et s’exercer aux vertus dans l’action concrète. La deuxième partie expose le discernement dans la Sainte Écriture. Patricia Rota Scalabrini énumère la découverte de la condition de créature dans la Torah, la dénonciation du mal et la révélation du temps favorable à la conversion (prophètes), le discernement (écrits de Sagesse) et les bienfaits de l’accompagnement (Tobie). Stefano Romanello présente une analyse ciblée sur Romains 12, où les croyants privés de la garantie de la seule Torah doivent désormais s’exercer à « un cercle herméneutique entre la vie, renouvelée par la foi, et le discernement éthique surce qui est le mieux, qui convient à la vie de foi et à la volonté de Dieu » (p. 178-179). Dans la troisième partie, où la théologie dialogue avec la philosophie, un article sur « la sagesse pratique (phrónēsis) d’Aristote et la prudence de Kant » (p. 225-264), rédigé par Antonio Da Re, met en évidence leur rapport différent à la vie concrète. La réduction opérée par Kant dans la Critique de la raison pratique, aux seuls impératifs hypothétiques (règles d’habileté) et catégoriques (moraux), laisse de côté les impératifs pragmatiques (prudence et bien-être). Les préceptes de la vertu sont considérés comme des devoirs imparfaits car trop imprécis: il faut réintroduire un jugement de prudence pour savoir comment les mettre en œuvre en situation. Ce constat introduit le gros chapitre conclusif sur « Prudence et discernement, loi et conscience » (p. 265-389). Chiodi présente de manière détaillée la doctrine thomiste qui juxtapose la conscience (discernement intellectuel du bien et du mal) et la prudence (jugement sur la bonté d’un acte précis, qui intègre la part des inclinations et des appétits, tout en les régulant). C’est ce point qu’il faut faire évoluer selon Chiodi pour aboutir à une théorie de la conscience qui appréhende toute la vie de l’homme et pas seulement sa raison, préservant le lien entre émotion et action. Il conclut par une reprise systématique sur le discernement: l’homme, interlocuteur de Dieu dans l’alliance, bénéficie d’une conscience singulière inscrite dans l’histoire; la promesse divine est soumise à l’épreuve du réel et du mal, d’où le processus vertueux du discernement qui « s’inscrit dans le sentir,le penser et le vouloir, selon la circularité entre passivité, intelligence et activité qui caractérise la conscience morale » (p. 375). Ainsi se construit « un cercle vertueux entre l’expérience (particulière), le bien (rationalité ou normes universelles), et la décision (singulière) » qui donne la connaissance du « bien concrètement possible » dont la conscience lui sera redevable à l’avenir pour préciser la norme. (C.F.)
Fonte da: Recherches de Science Religieuse
23 luglio 2021
La «fede non è riducibile a una conoscenza superiore di verità accessibili solo mediante la Rivelazione, ma è l’atto della coscienza che dà credito alla verità che le si manifesta come degna di essere creduta» (207). Pensiamo di non essere fuori strada rimarcando la dimensione di fede all’inizio di questa recensione a un testo di teologia che fa della coscienza la categoria centrale della riflessione teorica in esso proposta. E fa del discernimento, forma della phronesis (tradotta sia con «prudenza», in particolare nella parte dedicata all’esame dell’opera di Tommaso, sia con «saggezza»), una pratica che si distende nel tempo e impegna la coscienza nella sua totalità. Il libro stesso, attraverso il contributo di diversi autori, è un percorso che invita a mantenere uno sguardo aperto – si direbbe «ermeneutico» – dalle parole del titolo all’orizzonte più vasto entro cui esse emergono. La linea dell’orizzonte è disegnata dal rapporto tra filosofia e teologia morale la cui stretta relazione dialogica, particolarmente rilevante per comprendere l’esperienza morale, è (anche) testimoniata dalla traduzione, operata da S.Tommaso, dell’aristotelica phronesis con prudentia. Al riguardo, in uno dei saggi di M. Chiodi, vengono esaminate le proposte teoriche di alcuni studiosi la cui ricognizione critica porta a riconoscere la necessità di superare decisamente lo schema che giustappone «naturale» e «soprannaturale» in direzione di una sfida teorica che si proponga di comprendere non tanto il ruolo della ratio nella fides teologica, quanto soprattutto il compito della fides nella ratio filosofica. La giustapposizione «naturale» e «soprannaturale» ha effetti ricadenti su un altro rapporto cruciale per intendere discernimento e phronesis, quello tra morale e spiritualità. L’affondo critico sulla disconnessione operatasi tra le due discipline si sostiene sull’idea portante che esperienza morale e spirituale non designano due luoghi paralleli, dai confini evidenti nella pratica, ma trascurati nella teoria, bensì istanze che raccontano l’unica esperienza umana. Ciò fornisce l’argomentazione per proporre lo scioglimento della perdurante riserva che morale e spiritualità hanno stabilito rispettivamente sui comandamenti e sui consigli, le due storiche categorie ermeneutiche a cui ricondurre, in termini francamente dualistici, l’esperienza cristiana ordinata alla «perfezione» e l’esperienza cristiana comune. L’affondo sul significato e sull’esercizio del discernimento spirituale è condotto da Ezio Bolis che esamina il pensiero di due figure emblematiche, Ignazio di Loyola e Francesco di Sales, maestri nell’arte del discerni- mento e pedagoghi fondamentali per le future generazioni cristiane. Della ricchezza del saggio do solo alcune note: i legami Chiesa-Spirito-discernimento su cui si sofferma s. Ignazio; la maestria di Francesco di Sales nell’esplorare i sentimenti e restituirli nella loro forza spirituale e morale nell’esercizio del proprio ministero. L’orizzonte su cui è diretto lo sguardo restituisce a questo punto il primo referente del discernimento: la Parola. L’approccio con il quale ci si accosta mostra che la Parola biblica ha un carattere storico che istituisce un nesso ermeneutico tra la vicenda singolare di Gesù, nella quale si compie la promessa fatta a Israele, e la storia universale dell’uomo che della promessa è destinatario e «donatario». La parte teologico-biblica, posta dopo la sezione storico-sistematica (in modo da scoraggiare l’idea che la Scrittura, laddove sia posta al primo posto costituisca una specie di solenne premessa dalla quale ricavare in presa diretta norme morali e spirituali) è condotta da Patrizio Rota Scalabrini per l’Antico Testamento e da Stefano Romanello per il Nuovo Testamento di cui sceglie di trattare la Lettera ai Romani. La prospettiva d’indagine di Rota Scalabrini è tematica e in tale senso individua ed esamina alcune pericopi della Torah, dei Profeti, articolati in anteriori e posteriori, e degli Scritti. Dall’esame dei testi, l’autore giunge ad alcune interessanti conclusioni che qui riportiamo in estrema sintesi: il discernimento come opera fondamentale non solo per il singolo, ma per l’intera comunità; l’innesto del discernimento nell’albero della sapienza biblica il quale concorre all’apprendimento dell’arte del vivere. Il lavoro di Romanello è impostato sull’indagine lessicale e contestuale del termine «discernimento» in s. Paolo. Il testo di Romani 12, sviscerato nella sua profondità semantica, viene restituito nella propria inesauribile ricchezza teologica di cui mettiamo qui in luce solo due aspetti: il ruolo della coscienza come soggetto del discernimento e il significato di «mente», istanza antropologica globale, e quindi anche morale, caratterizza- ta dal profilo eminentemente pratico. La sezione biblica apre alla consistente III sezione del saggio che, composta di 3 corpo- si capitoli, guida lo sguardo verso il centro dell’orizzonte. Il contributo di Antonio Da Re approfondisce la nozione di phronesis in Aristotele e di prudenza in Kant. Il saggio ricostruisce il cammino semantico del concetto di «saggezza pratica», dal suo essere virtù cardinale per la vita etica alla sua espunzione dall’ambito morale a opera di Kant secondo il quale la prudenza è preposta alla formulazione di determinati imperativi ipotetici, ovvero fornisce consigli di natura empirica volti ad assicurare il benessere materiale. Avvicinandosi al punto focale dell’orizzonte, lo sguardo è sollecitato a tornare a scrutare s. Tommaso per il quale la virtù della prudenza riveste un ruolo decisivo, mentre, almeno a prima vista, non altrettanto succede con discretio. In ben 70 pagine d’analisi tanto accurata quanto puntuale Maurizio Chiodi s’impegna sulle pagine tommasiane ricavandone alcune piste che incoraggiano ulteriori riprese e ripartenze. Qui possiamo solo suggerire alcuni punti: la stretta relazione tra prudentia e discretio con l’attribuzione a quest’ultima di una valenza morale; l’approfondimento dell’elaborato rapporto tra la deliberazione (consilium rationis), la decisione/scelta (electio voluntatis) e il consensus; il rapporto ratio speculativa/ ratio practica; il problematico statuto della libertà; il nesso tra la prudenza nel suo senso fondamentale di recta ratio agibilium e la conscientia intesa come giudizio della ratio practica. Proprio dalla coscienza, cioè dal punto che per Tommaso è la conclusione, riparte la proposta teorica che si propone come obiettivo una teoria che garantisca il rapporto tra la singolarità della fede cristiana e l’universalità dell’esperienza antropologica, mostrando come questa abbia una forma insieme libera ed interpellata, quindi non absoluta. L’impegno etico è autorizzato da una promessa di bene, e dunque da una passività, che lo anticipa e lo sollecita assegnando alla libertà della coscienza un compito adeguato al dono che la istituisce. Entro questa visione che sostiene il rifiuto di ogni dualismo – oggettivo / soggettivo, universale dato a priori / singolare che ne sarebbe la semplice applicazione – la phronesis permette di superare la sterile contrapposizione che nella coscienza oppone la via absolutamente inventiva e la via sillogistico-deduttiva. Inscindibile dalla phronesis, anzi identificabile con la stessa, il discernimento è una pratica che si distende nel tempo e impegna la coscienza nella totalità. L’esposizione di una fenomenologia ermeneutica del discernimento articolata in tre scansioni, sentire, pensare, volere disegna una «sorta di metodica del giudizio morale» nella quale il saggio trova il culmine pratico.
fonte da: Rivista Il Regno-attualità (n.14-2021)
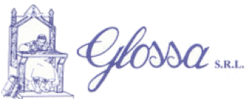
Recensioni